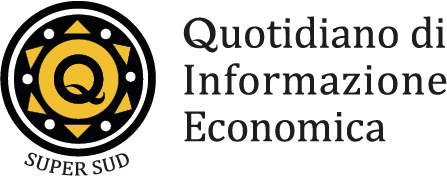Viaggio nell’Icam di Avellino, come si vive nelle sezioni per nove piccoli
24 Aprile 2022
Ecco lo stato di salute del mattone, classico bene rifugio degli italiani
24 Aprile 2022“Mai più bambini in carcere. Anche un solo bambino costretto a vivere ristretto è troppo”. Davanti al Parlamento, lo scorso 17 febbraio, il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha ribadito quello che è il primo obiettivo del governo. Ma, come dimostrano proprio i 21 che ancora vivono dietro le sbarre, riuscirci è compito molto più arduo. In realtà, dei ventuno bambini, quelli che ad oggi si trovano in un carcere vero e proprio sono 6 e sono tutti nella sezione femminile di Rebibbia, insieme a 4 madri, due delle quali hanno condanne definitive. A gennaio non ce ne era nessuno e a fine febbraio c’era un solo bambino: sono numeri che cambiano ogni mese e in ogni caso si cerca di ridurre al massimo il numero dei piccoli nei penitenziari. Per tutti gli altri, invece, la loro casa si chiama Istituto a custodia attenuata per madri detenute, Icam. Introdotti con la legge 62 del 2011, sono strutture dedicate esclusivamente a donne con figli fino a 6 anni, età che sale a 10 se la pena è definitiva. La legge di 11 anni fa ha previsto anche le case di famiglia protette, senza però indicare alcun onere per lo Stato. Il risultato è che le case famiglia, in tutta Italia, sono soltanto due, la casa di Leda a Roma e l’associazione Ciao a Milano. La strada per cambiare la situazione, però, è aperta. Dal 2019 è ferma in commissione Giustizia una proposta di legge del deputato del Pd Paolo Siani che individua nelle case famiglia protette l’unico luogo dove possano vivere i bambini figli delle madri condannate, prevedendo l’obbligo per lo Stato a finanziarle, e introduce alcune modifiche al codice di procedura penale finalizzate a rendere possibile la detenzione negli Icam solo in presenza di “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”. Con la legge di bilancio 2020, inoltre, il governo ha stanziato 4,5 milioni per il triennio 2021-2023 proprio con l’obiettivo di potenziare le case famiglia. “Con questa disponibilità finanziaria – ha detto la ministra in Commissione Infanzia – si apre dunque una possibilità in più: spetta ora alle Regioni e agli Enti locali farsi carico di concrete iniziative nel settore dell’accoglienza delle detenute-madri”. Saranno i prossimi mesi a dire se, finalmente, si riuscirà a portare a zero quel numero. Nel frattempo, i bambini continuano a vivere in carcere e negli Icam. Di questi ultimi ce ne sono cinque in Italia ma uno, a Cagliari, è vuoto. A Venezia c’è un solo bimbo, nove piccoli vivono invece nell’Icam di Lauro, in provincia di Avellino: il più grande ha nove anni, il più piccolo quasi 2; altri tre bimbi sono nell’Icam di Torino, associato al carcere de Le Vallette e altri due in quello di Milano, che dipende dal carcere di San Vittore ma è esterno alla struttura penitenziaria. Quale sia la differenza fondamentale con un carcere, lo spiega il direttore dell’Icam di Avellino Paolo Pastena. Sono strutture “pensate dall’inizio con determinate principi che rispondono ad un’esigenza fondamentale, quella di non far sentire o comunque attenuare al massimo grado l’impatto del minore con una struttura di tipo penitenziario. Il personale svolge servizio in borghese, c’è un ampio ricorso alla videosorveglianza, si cerca di tenere gli spazi quanto più aperti possibile”. Tre anni fa, nel 2019, i piccoli in carcere erano molti di più: 48, più del doppio di quelli di oggi. Ed erano saliti a 59 all’inizio del 2020. Poi però è arrivato il Covid. Ed è triste constatare che il virus sia riuscito laddove le norme e la società, finora, hanno fallito. Ma è solo il primo paradosso di questa storia in cui la realtà è molto più complessa di quello che sembra. Dove la volontà deve fare i conti con i pregiudizi. Ci sono le responsabilità dei magistrati di sorveglianza, che hanno un’ampia discrezionalità sulla concessione delle misure alternative. Ci sono le condizioni oggettive di queste madri: la mancanza, per molte, di un domicilio vero e contesti familiari di assoluta indigenza che renderebbero l’alternativa dei domiciliari peggiore del carcere. E c’è un rifiuto generalizzato della società a ‘proteggere’ queste donne, e dunque a reinserirle in un contesto sociale e lavorativo adeguato, una volta concluso il percorso carcerario.