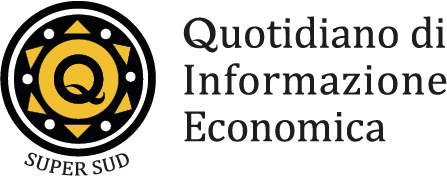Fase 2, Boccia: la Calabria corre, domani impugnazione dell’ordinanza Santelli
3 Maggio 2020
Fase 2: la paura fa ordinanza. Sbarramento dei governatori del Sud sui rientri. Ecco perché
3 Maggio 2020La Giornata mondiale della libertà di stampa: da John Milton ai giorni nostri
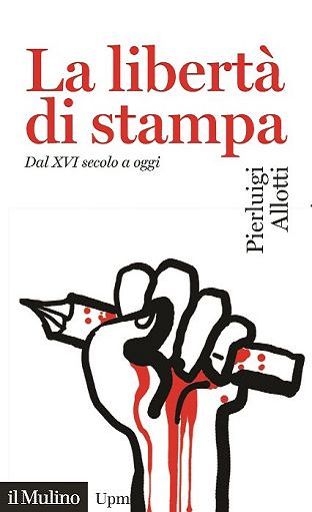
Roma, 3 mag. (askanews) - Secondo Mario Borsa, giornalista liberaldemocratico inviso al fascismo, autore nel 1925 di un aureo volumetto sulla libertà di stampa - di cui oggi si celebra la giornata mondiale -, il problema della libertà di stampa, "ridotto nei suoi termini essenziali, è di una trasparente chiarezza e di una grande semplicità": "libertà di stampa", afferma infatti Borsa, significa naturalmente "libertà di esprimere le proprie opinioni", ma, prima ancora, "assoluta indipendenza dagli uomini del Governo". In un libro di prossima uscita ("La libertà di stampa. Dal XVI secolo a oggi", il Mulino, in libreria dall'11 giugno), Pierluigi Allotti, giornalista e docente di Storia del giornalismo alla Sapienza di Roma, riprende e attualizza il volumetto di Borsa del 1925, esaminando in prospettiva storica il problema della libertà di stampa dalla prima età moderna fino ai giorni nostri. Allotti - interpellato da askanews in occasione della ricorrenza odierna - spiega nel suo libro che il concetto di libertà di stampa nasce e si afferma nell'Inghilterra del XVI secolo, come corollario alla libertà di coscienza, nell'ambito delle coeve guerre di religione. Già nel 1576 il parlamentare puritano Peter Wentworth aveva rivendicato il pieno diritto di parola in Parlamento anche sulle questioni religiose (diritto negato dalla regina Elisabetta I Tudor), e per questo venne arrestato e rinchiuso nella Torre di Londra. Nel 1644, in piena Rivoluzione puritana, il poeta John Milton pubblicò l'"Areopagitica", orazione contro la censura preventiva rivolta al Parlamento inglese. Milton, egli stesso vittima della censura, sosteneva che i libri non fossero "cose morte", bensì cose contenenti "in sé una potenza di vita che li rende tanto attivi quanto quello spirito di cui sono la progenie". Ragione per cui la soppressione di un libro, ai suoi occhi, equivaleva a un assassinio: "È quasi uguale uccidere un uomo che uccidere un buon libro. Chi uccide un uomo uccide una creatura ragionevole, immagine di Dio; ma chi distrugge un buon libro uccide la ragione stessa, uccide l'immagine di Dio nella sua stessa essenza". Nel 1651, nel "Leviatano", il filosofo Thomas Hobbes riconosceva invece ai sovrani assoluti la piena facoltà di giudicare "quali opinioni e dottrine siano avverse" e "quali siano favorevoli alla pace", e "chi debba esaminare le dottrine di tutti i libri prima che siano pubblicati", ma Baruch Spinoza, filosofo olandese fautore della tolleranza religiosa, nel suo "Trattato teologico politico" (1670) propugnerà poi per tutti la libertà di pensiero e di parola, una libertà tuttavia non illimitata: "È lecito a chiunque di pensare quello che vuole e di dire quello che pensa", sosteneva Spinoza, "purché parli semplicemente, e sostenga ciò che dice seguendo la sola ragione, e non con inganno, con ira e con odio". (segue)
Secondo Mario Borsa, giornalista liberaldemocratico inviso al fascismo, autore nel 1925 di un aureo volumetto sulla libertà di stampa – di cui oggi si celebra la giornata mondiale -, il problema della libertà di stampa, “ridotto nei suoi termini essenziali, è di una trasparente chiarezza e di una grande semplicità”: “libertà di stampa”, afferma infatti Borsa, significa naturalmente “libertà di esprimere le proprie opinioni”, ma, prima ancora, “assoluta indipendenza dagli uomini del Governo”. In un libro di prossima uscita (“La libertà di stampa. Dal XVI secolo a oggi”, il Mulino, in libreria dall’11 giugno), Pierluigi Allotti, giornalista e docente di Storia del giornalismo alla Sapienza di Roma, riprende e attualizza il volumetto di Borsa del 1925, esaminando in prospettiva storica il problema della libertà di stampa dalla prima età moderna fino ai giorni nostri. Allotti – interpellato da askanews in occasione della ricorrenza odierna – spiega nel suo libro che il concetto di libertà di stampa nasce e si afferma nell’Inghilterra del XVI secolo, come corollario alla libertà di coscienza, nell’ambito delle coeve guerre di religione. Già nel 1576 il parlamentare puritano Peter Wentworth aveva rivendicato il pieno diritto di parola in Parlamento anche sulle questioni religiose (diritto negato dalla regina Elisabetta I Tudor), e per questo venne arrestato e rinchiuso nella Torre di Londra. Nel 1644, in piena Rivoluzione puritana, il poeta John Milton pubblicò l'”Areopagitica”, orazione contro la censura preventiva rivolta al Parlamento inglese. Milton, egli stesso vittima della censura, sosteneva che i libri non fossero “cose morte”, bensì cose contenenti “in sé una potenza di vita che li rende tanto attivi quanto quello spirito di cui sono la progenie”. Ragione per cui la soppressione di un libro, ai suoi occhi, equivaleva a un assassinio: “È quasi uguale uccidere un uomo che uccidere un buon libro. Chi uccide un uomo uccide una creatura ragionevole, immagine di Dio; ma chi distrugge un buon libro uccide la ragione stessa, uccide l’immagine di Dio nella sua stessa essenza”. Nel 1651, nel “Leviatano”, il filosofo Thomas Hobbes riconosceva invece ai sovrani assoluti la piena facoltà di giudicare “quali opinioni e dottrine siano avverse” e “quali siano favorevoli alla pace”, e “chi debba esaminare le dottrine di tutti i libri prima che siano pubblicati”, ma Baruch Spinoza, filosofo olandese fautore della tolleranza religiosa, nel suo “Trattato teologico politico” (1670) propugnerà poi per tutti la libertà di pensiero e di parola, una libertà tuttavia non illimitata: “È lecito a chiunque di pensare quello che vuole e di dire quello che pensa”, sosteneva Spinoza, “purché parli semplicemente, e sostenga ciò che dice seguendo la sola ragione, e non con inganno, con ira e con odio”.
Il primo paese ad abolire la censura, nel 1695, fu dunque l’Inghilterra, dove nel corso del Cinquecento era stato istituito un severissimo sistema di controlli preventivi sulla stampa, il licensing system. Privilegi speciali erano stati riconosciuti dai sovrani inglesi alla corporazione degli stampatori e dei librai, la Company of Stationers, che deteneva il monopolio sulla produzione e il commercio librario. Inoltre, nel 1605, il famigerato tribunale della Camera stellata aveva stabilito che un’affermazione diffamatoria nei confronti del re o di qualsiasi altra persona pubblica, anche se veritiera, costituiva un crimine gravissimo punibile con la carcerazione e il taglio delle orecchie. Il licensing system decadde nel 1641 dopo che il cosiddetto “Lungo Parlamento” soppresse la Camera stellata, ma fu ben presto ripristinato dallo stesso Parlamento, a cui nel 1644 Milton rivolgerà il suo accorato appello contro la censura. Restaurata poi nel 1660 sul trono d’Inghilterra la monarchia Stuart, nel 1662 verrà adottato un nuovo licensing system, lasciato spirare definitivamente nel 1695 dal Parlamento di Londra, che giudicava ormai superato il monopolio della Company of Stationers, proprio come il filosofo John Locke. In Francia, ricorda nel suo libro Allotti, la libertà di stampa si affermò quasi un secolo dopo, allo scoppio della rivoluzione. Dopo la presa della Bastiglia, il 14 luglio 1789, a Parigi vi fu un fiorire di nuovi giornali, e la libertà di stampa fu proclamata dalla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” approvata il 26 agosto dall’Assemblea Nazionale. “La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni – essa affermava all’articolo 11 – è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge”. Mentre qualche anno prima, in Danimarca, il re Cristiano VII aveva introdotto la libertà di stampa in una forma illimitata, i rivoluzionari francesi stabilirono invece che una legge avrebbe dovuto reprimerne gli abusi e fissare dunque dei limiti ben precisi. Dirà d’altronde un giurista francese del diciannovesimo secolo, citato da Allotti: “La libertà illimitata della parola e della stampa, cioè la facoltà di tutto dire e tutto pubblicare, senza essere esposto né ad una repressione, né ad una responsabilità qualunque, è non un’utopia, ma un assurdo, che non può esistere nella legislazione di alcun popolo civile”. Si aprì così a Parigi, nell’estate del 1789, un dibattito sui limiti della libertà di stampa e di parola, ancora aperto. Proprio a Parigi, nel gennaio 2015, il dibattito si riaccese dopo la strage al settimanale satirico “Charlie Hebdo”. Ci si interrogò – e ci si interroga tuttora, sottolinea Allotti – se sia lecito o meno fare satira sulla religione senza tener conto della sensibilità dei fedeli; qual è il limite invalicabile in questo ambito, semmai debba esservene uno.
Negli Stati Uniti, la libertà di parola e di stampa fu riconosciuta nel 1791 in una forma quasi assoluta dal Primo emendamento alla Costituzione, che dice: “Il Congresso non promulgherà leggi [?] che limitino la libertà di parola, o di stampa”. Il Congresso, dunque, non può toccare quella libertà in alcun modo. In realtà, nell’ultimo secolo – ricorda Allotti – la Corte Suprema americana, con una serie di storiche sentenze, ha definito l’effettiva portata del Primo emendamento, che non garantisce una libertà illimitata: non tutto si può dire e scrivere negli USA. La libertà di stampa sembrò trionfare definitivamente nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento. Il periodo compreso tra il 1870 e l’inizio della Grande Guerra, nel 1914, viene ricordato come un'”età d’oro” della stampa e del giornalismo. L’industria giornalistica si sviluppò, assumendo nuove dimensioni, grazie alle innovazioni tecnologiche, ma soprattutto grazie alla libertà di stampa riconosciuta ormai nei Paesi più avanzati. In Piemonte fu proclamata dallo Statuto albertino, concesso dal re Carlo Alberto di Savoia nel marzo del 1848, e applicato poi al Regno d’Italia nel 1861. I principali giornali italiani (“Corriere della Sera”, “stampa”, “Messaggero”, “Mattino”, “Resto del Carlino” e altri ancora) nacquero allora, dopo il 1870. Ma il giornalismo italiano, rimarca Allotti, conoscerà la sua “età d’oro” nel periodo giolittiano, all’inizio del Novecento. Anche in Gran Bretagna, intorno alla metà dell’Ottocento, furono abolite le cosiddette “Taxes on knowledge”: imposte sui giornali che costituivano un ostacolo alla diffusione della stampa radicale, costretta alla clandestinità. Scriveva nel 1858 il filosofo inglese John Stuart Mill: “È da sperare che sia trascorsa l’epoca in cui era necessario difendere la libertà di stampa come una delle garanzie contro un governo corrotto o tirannico. Possiamo supporre che non sia più necessario dimostrare che non si può consentire a una legislatura o a un esecutivo, i cui interessi non si identifichino con quelli dei cittadini, di imporre loro delle opinioni e di stabilire quali dottrine o argomentazioni essi possano ascoltare”.
In realtà, “l’epoca in cui era necessario difendere la libertà di stampa” non era affatto trascorsa (non lo è nemmeno oggi). I regimi totalitari degli anni Venti e Trenta del secolo scorso, spiega ancora Allotti, elaborarono una propria concezione della libertà di stampa, ritenendo che la stampa veramente libera fosse la loro e non quella dei regimi democratici. I comunisti, ad esempio, erano convinti che i giornali in Unione Sovietica fossero i più liberi perché in mano pubblica e al servizio esclusivo dei lavoratori. Lo stesso nell’Italia fascista: per i fascisti i giornali dovevano essere al servizio esclusivo dello Stato e della nazione, identificati dal regime con il fascismo. Mussolini, che in gioventù era stato un difensore della libertà di stampa, nel 1926 mise al bando i giornali antifascisti – già vessati da violenze e sequestri – e nel 1928, davanti ai direttori di 70 quotidiani, dichiarò: “La stampa più libera del mondo intero è la stampa italiana. (…) Il giornalismo italiano è libero perché serve soltanto una causa e un regime; è libero perché, nell’ambito delle leggi del regime, può esercitare e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di propulsione. (…) Io considero il giornalismo fascista come un’orchestra. Il “la” è comune. E questo “la” non è dato dal Governo attraverso i suoi uffici stampa, sotto la specie dell’ispirazione e della suggestione davanti alle contingenze quotidiane; è un “la” che il giornalismo fascista dà a se stesso. Egli sa come deve servire il regime. La parola d’ordine non l’attende giorno per giorno. Egli l’ha nella sua coscienza”. Lo scrittore francese Chateaubriand, citato in epigrafe da Allotti, diceva due secoli fa che “i nemici della libertà sono anzitutto gli uomini che hanno qualche cosa da nascondere nella loro vita; poi sono quelli che desiderano di non far conoscere al pubblico le loro azioni e le loro manovre, gli ipocriti, gli amministratori incapaci, gli autori fischiati, gli intriganti e i servitori di tutte le specie”. Oggi – afferma Allotti – i nemici della stampa libera sono gli stessi di allora: dittatori, politici corrotti, criminali, che agiscono nell’ombra e temono i giornalisti il cui compito primario è proprio quello invece di illuminare gli affari pubblici per renderli intellegibili ai cittadini. Nel ventunesimo secolo, poi, dopo l’avvento di Internet, i rischi per i giornalisti sono ancora più grandi perché i loro servizi possono avere davvero una risonanza globale e sono dunque più esposti, e i numeri lo testimoniano: ogni anno ne vengono uccisi decine e centinaia sono imprigionati. Non a caso, nel dicembre 2018, il prestigioso settimanale americano “Time” ha nominato “persona dell’anno” i “Guardiani”, ovvero i giornalisti custodi della verità “che rischiano tutto per raccontare la storia del nostro tempo”. Ai “Guardiani” il settimanale ha dedicato quattro copertine diverse: una al giornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinato il 2 ottobre 2018 all’interno del consolato saudita di Istanbul (il suo corpo fu smembrato e non è mai stato rinvenuto); una ai cinque giornalisti della “Capital Gazette” di Annapolis, in Maryland, uccisi il 28 giugno 2018 da un uomo armato durante un assalto in redazione; una a Wa Lone e Kyaw Soe Oo, giornalisti dell’agenzia di stampa Reuters arrestati e condannati in Myanmar (sono stati liberati poi nel maggio 2019); una alla giornalista filippina Maria Ressa, perseguitata dal presidente del suo paese, Rodrigo Duterte. Ma anche in Italia ci sono oggi diversi giornalisti minacciati per quello che scrivono e costretti a vivere sotto scorta.